Precedenti capitoli
di uno o più Viaggi
Nel 1541, il ventenne nobile mercante fiorentino Lodovico Guicciardini venne ad Anversa
per aiutare lo zio Girolamo nei suoi affari. La città gli piacque così tanto
che continuò a viverci per il resto della sua vita, fino alla morte avvenuta
nel 1589. Quanto i Paesi Bassi lo affascinassero è evidente dalla sua Descrittione di tutti i Paesi Bassi,
scritta probabilmente senza troppe pretese o aspettative , comunque sia la
prima monografia dedicata all’angolo settentrionale dell’impero asburgico.
La sua
opera precedente, un trattato storico con particolare attenzione ai Paesi
Bassi, i Comentarii delle cose più
memorabili seguite in Europa, era già stata pubblicata nel 1565. Nella sua Descrittione,
Guicciardini descrisse le varie province dei Paesi Bassi con particolare
attenzione alle città più importanti, ma trattò anche questioni come il
commercio e l’industria, le scienze e le arti.
Anversa è
il punto di partenza di Guicciardini. Questa città riceve la massima attenzione
e nella prima edizione – l’unica - oltre alla pianta della città, presenta
anche una veduta della Cattedrale di Nostra Signora e del Municipio, integrata
nell’edizione Plantin del 1581 con
le immagini dei Borsa e Hanzehuis. Le altre quattordici carte riguardano i
Paesi Bassi (l’unica incisione su rame), le province del Brabante, dell’Olanda
e delle Fiandre e una selezione di dieci città. Nell’edizione Plantin, alla
quale contribuì lo stesso Guicciardini, il numero delle illustrazioni fu
notevolmente ampliato, arrivando a 55 in totale, ora tutte in incisione su
rame. Oltre ai Paesi Bassi, otto province, ducati, contee o principi vescovi
ricevono una mappa, più altre 41 città.
Ma anche
qui la posizione centrale di Anversa rimane intatta, con quattro paesaggi urbani
oltre alla mappa della città. Un’edizione francese pubblicata da Plantin nel 1582 conteneva già 78 mappe,
planimetrie e vedute della città. Quando la Descrittione
fu pubblicata nei Paesi Bassi settentrionali a partire dal 1609, le
illustrazioni furono nuovamente ampliate, arrivando ora a 93. Nelle edizioni
successive il numero a volte superò addirittura il centinaio. Il grande merito
dell’opera qui discussa è che le diverse immagini della stessa città - a volte
fino a sette - vengono distinte e collegate alle innumerevoli diverse edizioni
dell’opera pubblicate nell’arco di quasi un secolo.
Forse Guicciardini non immaginava che il suo lavoro pionieristico avrebbe continuato a suscitare così tanto interesse per così tanto tempo. Perché anche se negli anni Sessanta del Cinquecento scriveva ancora energicamente i Paesi Bassi, erano tempi turbolenti e sarebbero rimasti tali per qualche tempo a venire. Ma forse quei tempi turbolenti contribuirono al fatto che la sua opera del 1567 sarebbe rimasta un classico fino al XVII secolo inoltrato: almeno le ultime edizioni in folio dell’Olanda settentrionale spesso coincidono bene con momenti come l’inizio e la fine dei Dodici Anni e la pace di Münster.
Quando è
stato creato il libro, la pace era solo apparente. Ad esempio, Willem Silvius,
il primo editore di Anversa della Descrittione,
ottenne il privilegio di pubblicazione per dieci anni nel 1565. L’anno successivo scoppiò la Beeldenstorm. Ciò tuttavia
non impedì che l’opera comparisse in italiano e francese nel 1567 e che ne fosse pubblicata una ristampa francese nel 1568. Anni dopo, anche il suo
concittadino Christoffel Plantin ne vide dei meriti e, alle spalle di Silvius,
ottenne il privilegio di una nuova edizione il 1° luglio 1580.
Considerati
i suoi ingenti investimenti - non solo Guicciardini stesso fornì alcune
aggiunte al suo testo originale e Plantin fece stampare le 17 tavole in gran
parte da xilografie incise in rame e ampliando il numero delle tavole a 55 - lo
stampatore del libro annuncerà con soddisfazione, poco prima della
pubblicazione la quale mise in ansia gli spagnoli: “dopo tutto, i Paesi Bassi
settentrionali stanno riflettendo sulla loro posizione e non più o solo
geografica”.
Plantin
optò saggiamente per una sicura via di mezzo e decise di lasciare aperto il
posto riservato allo stemma e al ritratto del monarca regnante, in modo che, a
seconda della situazione, lì potessero essere onorati Filippo II o il duca d’Angiò.
Il libro
venne pubblicato ai primi di marzo del
1581 e poco dopo, il 26 luglio, l’edizione italiana del 1581 è nota per gli
spazi vuoti o le armi e i ritratti di Filippo II incollati; l’edizione francese
del 1582 per i detti latini stampati o le armi e i ritratti incollati del duca
d’Angiò. In definitiva, la seconda edizione italiana, del 1588 - dopo la presa
di Anversa da parte del duca di Parma nel 1585 - rifletterebbe fedelmente la
situazione stabilizzata e includerebbe semplicemente lo stemma e il ritratto di
Filippo II in stampa.
L’EDITTO
Giunsero
così alla Casa del Comune, dinnanzi alla quale stavano, a cavallo, gli araldi
che suonavano la tromba e battevano i cimberli; il prevosto con la verga della
giustizia; e il procuratore comunale, anch’esso a cavallo, che teneva con due
mani un’ordinanza dell’Imperatore e si preparava a leggerla alla folla radunata
intorno. Claes udì chiaramente che si proibiva di nuovo, a tutti in generale e
in particolare, di stampare leggere possedere o divulgare scritti, libri o
dottrine di Martin Lutero, di Giovanni Wycleff, Giovanni Huss, Marcilius de
Padua, Aecolampadius, Ulricus Zwynglius, Philippus Melancthon, Franciscus
Lambertus, Joannes Pomeranus, Otto Brunselsius, Justus Jonas, Joannes Puperis e
Gorcianus, i Nuovi Testamenti stampati da Adriano de Berghes, Cristoforo de
Remonda e Giovanni Zel, pieni di eresie luterane e simili, riprovati e condannati
dalla Facoltà teologica dell’Università di Louvain.
Similmente
si vietava di dipingere o far dipingere o ritrarre pitture o figure obbrobriose
di Dio e della benedetta Vergine Maria o
dei suoi Santi; di rompere, spezzare o cancellare le immagini fatte in onore
ricordo o memoria di Dio, della Vergine Maria e dei suoi Santi riconosciuti
dalla Chiesa.
Inoltre,
diceva l’editto, nessuno, di qualsivoglia stato o condizione, poteva parlare o discutere
della Sacra Scrittura, fosse pure in materia dubbia, se non era teologo di fama
e laureato da una università illustre.
Sua Maestà
stabiliva, fra le altre pene, che le persone sospette non potessero mai più
esercitare una professione onorevole. Quanto a coloro che fossero ricaduti nel
medesimo errore o a quelli che vi si fossero ostinati, sarebbero stati
condannati a esser bruciati a fuoco lento o vivo, in una capanna di paglia o
attaccati a un palo, ad arbitrio del giudice.
Gli altri
sarebbero stati giustiziati con la spada se erano nobili o buoni borghesi; i
contadini con la forca e le donne con la fossa. Le loro teste, per servir
d’esempio, dovevano essere piantate sopra un’asta. V’era poi, a beneficio
dell’Imperatore, la confisca dei beni di tutti costoro, nei casi soggetti a confisca.
Sua Maestà
accordava ai delatori la metà di quanto possedevano i morti, se i beni non
oltrepassavano le cento lire grosse, moneta di Fiandra. Quanto alla sua parte,
l’Imperatore si riservava d’impiegarla in opere pie e misericordiose, come
aveva fatto per il sacco di Roma.
LA VENEZIA DEL NORD
La città
sembra galleggiare sulle acque e sembra la sovrana degli abissi. È affollato di
mercanti di ogni nazione e i suoi abitanti sono essi stessi i mercanti più
eminenti del mondo. A prima vista non sembra essere la città di un popolo
particolare, ma comune a tutti, come centro del loro commercio. Le navi in questo porto sono così numerose, da nascondere
quasi l’acqua in cui galleggiano; e gli alberi guardano in lontananza come una
foresta.
‘Ho guardato, con insaziabile curiosità, questa
grande città, in cui tutto era in movimento’.
Questa
rappresentazione di Amsterdam da parte di un autore del XVII secolo ci riporta al tempo in cui nessun rivale aveva
ancora contestato alla città il suo monopolio commerciale, quando il suo
spettacolo pieno e radioso colpiva gli occhi di ogni visitatore. Per quanto
siamo tentati di ricordare questo glorioso passato (il periodo e i diretti
dintorni del suo più grande pittore), prendiamo naturalmente come base lo stato
attuale di Amsterdam, e così facendo notiamo dolorosamente la perdita di
preziose reminiscenze che il corso di tempo ha inevitabilmente comportato.
Ma
rendendoci conto che tale perdita non è solo la conseguenza dell’incuria e
della mancanza di rispetto, e che in larga misura la vita moderna, con le sue
diverse esigenze e intensità, provoca con la forza cambiamenti crudeli,
dobbiamo vincere i nostri rimpianti e guardare piuttosto con occhi aperti la
vitalità di la città e la rinnovata energia della sua esistenza attuale.
Triste è
infatti l’aspetto delle città, dette ‘città morte’, che conservano il loro
antico aspetto architettonico, e dove ogni vita sembra estinta. Non sono altro
che le loro ombre e un grido perpetuo contro i rovesci del Destino o il
rilassamento dell’energia umana, che si è rivelata incapace di portare avanti
le aspirazioni delle generazioni precedenti.
Fortunatamente Amsterdam è sfuggita a questa disgrazia, perché la sua scintilla di vita non si è mai spenta del tutto, l’ardente vigore dei suoi abitanti, che contribuì ad aumentare la prosperità della città nel XVII secolo, può sembrare un ricordo ancora vivo che si manifesta con l’antica energica intraprendenza da cui trarre spunto da taluni artisti, rispetto al declino all’inizio del diciannovesimo secolo.
Quando
Motley dice, nella sua ‘Storia dei Paesi Bassi Uniti’, che la Repubblica olandese
è ‘nata e sostenuta dal mare’, dobbiamo applicare questa affermazione, in primo
luogo, alla sua città più importante, Amsterdam; e se poi ricordiamo che la
soppressione (al tempo della dominazione spagnola) di una nazione abituata alle
attività marittime è una delle cose più rare nella storia, arriveremo a
comprendere meglio la successiva vitalità artistica di Amsterdam.
In una
città dove la vita ha mantenuto il suo corso, non possiamo aspettatevi di
trovare interi quartieri conservati, così come apparivano nella prima metà del
XVII secolo; l’assetto generale della città è però così originale ed efficace
che il suo impianto indistruttibile è sopravvissuto fino ai nostri giorni, e sono
poche le città al mondo che possiedono una così affascinante singolarità,
Venezia è probabilmente l’unica città che offre un’attrazione simile, anche se
differisce sotto molti aspetti. Quindi, il soprannome di Amsterdam quale Venezia del Nord, è facilmente spiegabile e
appare già negli scritti di Guicciardini,
lo storico del XVI secolo. È l’acqua che conferisce alla città il suo fascino
particolare, e mentre alcuni canali dovettero essere riempiti per creare
alloggi per le carrozze nelle parti antiche, la maggior parte è stata
preservata, e sebbene nell’acqua si riflettano altre facciate di case, il
visitatore può ricostruire, senza grandi difficoltà, una visione dell’Amsterdam
ai tempi di Rembrandt.
Quando Rembrandt arrivò ad Amsterdam intorno al 1631, trovò la città cambiata rispetto ai suoi antichi confini con nuovi quartieri sorti sui campi esterni, che una generazione precedente aveva conosciuto solo come prati e orti. L’artista deve aver notato molti cambiamenti anche da quando trascorse i suoi anni di apprendistato ad Amsterdam nello studio di Pieter Lastman, tornando di nuovo nella sua città natale Leida durante i sette o otto anni intermedi.
UN FILOSOFO
Alcuni anni
prima Spinoza ricevette la visita di Henry
Oldenburg, che stava allora facendo uno dei suoi periodici viaggi in giro per
il continente. Nato verso il 1620 a Brema, dove il padre insegnava filosofia (e
dove egli fu battezzato originariamente Heinrich), Oldenburg a partire dal 1639, poco dopo la laurea
in teologia, aveva abitato a lungo in Inghilterra, lavorando forse come
precettore per qualche famiglia benestante. Nel 1648, aveva fatto ritorno in continente, per viaggiare e passare
di tanto in tanto a casa. Nel 1653,
il consiglio comunale di Brema, favorevolmente impressionato dai legami che
Oldenburg ancora manteneva con l’Inghilterra, gli aveva chiesto di tornare in
quel paese per negoziare con Oliver Cromwell la neutralità di Brema nel primo
conflitto anglo-olandese. Ed egli si era fermato poi in Inghilterra per una
buona metà degli anni cinquanta, studiando a Oxford e facendo il precettore di
alcuni giovani aristocratici del posto.
Prima di
assumere questo ed altri successivi incarichi, Oldenburg come il Guicciardini,
volle fare ancora un viaggio a Brema e nei Paesi Bassi, aveva in mente di
recarsi in visita da Huygens, al quale voleva raccontare delle ultime scoperte
scientifiche fatte in Inghilterra. Ma prima di andare all’Aia decise di passare
da Amsterdam e Leida, e in una di queste città, o forse in entrambe, sentì
parlare di Spinoza, forse proprio ad
Amsterdam da amici collegianti o cartesiani, quali Peter Serrarius o Jan
Rieuwertsz, o forse a Leida da Johannes Coccejus, libero docente di teologia
all’università del posto e suo ottimo amico.
Stuzzicato dalla curiosità, a metà luglio Oldenburg partì dunque da Leida per recarsi a Rijnsburg, dove Spinoza si era da poco trasferito. E i due si intesero subito assai bene: il primo giro di lettere dopo la visita è tutto un complimento reciproco e un augurio di rivedersi presto. Spinoza dovette fare di sicuro un certo effetto sul suo ospite, se questi gli scrisse che
‘è stato così penoso separarmi da voi che non
vedo l’ora, adesso che sono in Inghilterra, di riunirmi subito a voi, per
quanto è possibile, almeno per lettera’.
Oldenburg
ribadiva poi a Spinoza che occorreva
‘mantenere stretti i vincoli della nostra
amicizia, coltivandola assiduamente con tutte le risorse di una reciproca
solidarietà’.
Spinoza, dal canto suo, si diceva ‘lusingato dalla vostra
amicizia’, pur manifestando qualche cautela, forse per paura di sembrare troppo
audace agli occhi del più esperto e navigato Oldenburg:
‘Per quanto mi sembra addirittura presuntuoso
ardire a entrare in amicizia con voi, in considerazione specialmente del fatto
che tutto è comune fra amici, e i beni spirituali soprattutto, lo farò
tuttavia, attribuendone il merito a voi, piuttosto che a me stesso, alla vostra
generosità e benevolenza.
Esercitando in massimo grado la prima per
abbassare voi stesso e la seconda per valorizzare la mia persona, mi avete
incoraggiato ad accettare l’intima amicizia che insistete a offrirmi e a
ricompensarvi a mia volta con quella che vi siete degnato di sollecitare da me
e che io avrò cura di mantenere costante e duratura’.
A casa di Spinoza, i due discussero di Dio e dei suoi attributi, dell’unione dell’anima e del corpo, e della filosofia di Cartesio e Bacone, tutti argomenti di stringente attualità per Spinoza. Da diversi mesi egli stava infatti lavorando a un trattato filosofico sistematico. In quest’opera, voleva passare in rassegna tutte le questioni metafisiche, etiche, teologiche, psicologiche, metodologiche, fisiche ed epistemologiche sulle quali aveva riflettuto per lungo tempo e che erano state solo abbozzate (come tutta la “Filosofia”) nel Trattato sull’emendazione dell’Intelletto.
Al tempo
della sua prima risposta a Oldenburg, il Breve
trattato su Dio, l’uomo e suo bene era ancora lungi dal possedere una forma
definitiva. Con ogni probabilità, Spinoza
aveva iniziato a scriverlo quando ancora abitava ad Amsterdam, forse su
pressione degli amici.
Questi dovevano
aver capito che Spinoza faceva assai più che discutere con loro di teorie
altrui, in primo luogo di Cartesio, e potrebbero avergli chiesto dunque una
concisa esposizione delle sue specifiche idee filosofiche, magari per iscritto,
così da poterle studiare e analizzare meglio, Spinoza li accontentò scrivendo un’opera in latino, probabilmente tra la metà del 1660 e la partenza per
Rijnsburg. E quando gli fu chiesta una versione in olandese, forse per coloro i
quali non sapevano abbastanza bene il latino, Spinoza cominciò a rimaneggiare il testo, introducendo via via
aggiunte e correzioni, talvolta in risposta alle obiezioni e ai consigli degli
amici, un lavoro di stesura e revisione che continuò per tutto il 1661.
Anche se, a quanto pare, Spinoza prese in considerazione l’ipotesi di pubblicare il trattato, le sue osservazioni alla fine dell’opera chiariscono che si trattava in effetti di una presentazione complessiva della sua filosofia agli amici:
‘Per concludere, mi rimane ancora da dire agli
amici per i quali scrivo questo [trattato]: non siate meravigliati di queste
novità, poiché sapete molto bene che una cosa non cessa di essere verità, solo
perché non è accettata da molti. E poiché voi non ignorate neppure la
condizione dell’epoca in cui viviamo, voglio ancora insistere pregandovi di
essere ben attenti per quanto riguarda la comunicazione di queste cose ad altri’.
Spinoza riconosceva così apertamente, non solo l’estrema
originalità delle proprie idee, ma anche il fatto che esse sarebbero apparse
troppo radicali agli occhi delle autorità calviniste olandesi. Il Breve trattato comincia in modo
innocente, con diverse prove dell’esistenza di Dio. E, alla stregua del Trattato sull’emendazione dell’intelletto,
si conclude con l’affermazione che la felicità e il bene dell’uomo, ossia la
nostra ‘beatitudine’, consistono nella conoscenza di Dio e del modo in cui ogni
cosa dipende da lui. A ciò si unisce l’esortazione ad amare Dio come il nostro
sommo ed esclusivo bene.
Ma il Dio
di cui Spinoza dimostra l’esistenza
non è un Dio parente di quello della Chiesa riformata, o di qualsiasi altra
religione cattolica o protestante. Spinoza
non parla di Dio in termini di libero e benevolo creatore. Il suo Dio non è un
Dio legislatore e giudice nel senso tradizionale di questi termini. Non è fonte
di conforto, ricompensa o castigo, e non è neppure un essere al quale si
possano rivolgere preghiere.
Spinoza nega apertamente che Dio sia onnisciente, compassionevole e saggio. Semmai, Dio è ‘un essere del quale sono predicati infiniti attributi’. Dio è quella che Spinoza chiama la ‘sostanza’. E la sostanza è semplicemente l’essere reale. È, per definizione e per dimostrazione, infinitamente perfetto, così come è infinito e unico nella sua specie. In altri termini, non è limitato da nessun’altra sostanza della stessa natura. Ed è anche indipendente sotto il profilo causale da ogni altra cosa che si trovi al di fuori di lui: la sostanza esiste in modo necessario e non contingente.
Dunque, la
sostanza pensante, la sostanza di cui il pensiero è un attributo o una natura,
è infinita e unica: esiste una sola sostanza pensante. E lo stesso si può dire
della sostanza estesa, o della sostanza di cui l’estensione (o la
dimensionalità, l’essenza della materia) è un attributo.
In realtà,
il pensiero e l’estensione sono solo i due attributi, o le due nature, di
un’unica sostanza infinita e perfetta. La sostanza, di cui il pensiero è un
attributo, è numericamente identica alla sostanza di cui l’estensione è un
attributo. Tutti gli attributi che esistono in natura, e noi ne conosciamo solo
due, sono, a dispetto della loro apparente diversità di sostanza, differenti
aspetti di un unico essere singolare.
La natura è
un’unità, un intero, al di fuori del quale non c’è nulla. Ma se la Natura è
soltanto la sostanza composta di infiniti attributi, l’unità produttiva
soggiacente a ogni cosa, allora la Natura è Dio. Ogni cosa in natura ‘esiste ed è
compresa in Dio’. Dio non si trova al di fuori della natura. Non è una causa
distaccata. Semmai, Dio è la causa immanente e portante di tutto quanto esiste.
Dio è sì la libera causa di tutto, ma questo non vuol dire che le cose
potrebbero accadere diversamente da come accadono e potrebbero essere più o
meno perfette.
Ogni cosa discende da Dio, dalla Natura, secondo una necessità eterna. Non c’è niente di contingente o accidentale in natura. Non ci sono eventi spontanei o senza causa. Niente avrebbe potuto non accadere così come è accaduto. Tutto è predestinato e necessitato dagli eterni attributi di Dio.
Spinoza chiama Dio Natura naturans, ossia ‘Natura naturante’, la dimensione attiva, eterna e
immutabile della natura. La ‘Natura’, in questo senso, è invisibile: consiste
unicamente negli attributi invisibili ma universali del pensiero e dell’estensione,
le due nature a noi note di tutto ciò che esiste, e nelle leggi che governano
ciascuna di esse, le leggi del pensiero e le leggi dell’estensione (ossia la
geometria). Il mondo invece, così come lo conosciamo, è il mondo della materia
e del movimento (che include i corpi fisici) e il mondo dell’intelletto (che
include le idee o i concetti dei corpi), e questo mondo è Natura naturata. Esso
non è altro che il prodotto della sostanza infinita che lo genera e lo
sorregge.
Le cose
singolari e le loro proprietà corrispondono a quelli che Spinoza chiama i ‘modi’ della sostanza, i modi in cui gli attributi
della sostanza si esprimono. E, a differenza della sostanza, essi nascono e
muoiono secondo le leggi immutabili della natura. Questo è lo sfondo metafisico
dell’etica e dell’antropologia di Spinoza.
Dato che tutto in natura semplicemente è, e discende necessariamente da Dio, una delle conseguenze del rigido determinismo di Spinoza è che il bene e il male non hanno alcuna realtà in sé. ‘Il bene e il male non esistono in natura’, egli insiste, ma sono solo ‘enti di ragione’, prodotti dell’intelletto. Il bene e il male sono sempre relativi al nostro punto di vista. Queste categorie morali sono semplici etichette che noi apponiamo alle cose quando esse si dimostrano o non si dimostrano all’altezza dei nostri ideali. Una persona ‘buona’ è semplicemente una persona che risponde ai nostri criteri di perfezione dell’essere umano, così come un cattivo martello è un martello che non corrisponde affatto alla nostra idea di martello perfetto.
L’essere
umano è un composto di anima e corpo.
…Ma, a
differenza di quanto accade con il dualismo della metafisica cartesiana, per Spinoza l’anima umana e il corpo umano
non sono due sostanze separate. La nostra anima è solo un modo di uno degli
attributi sostanziali di Dio, il pensiero. Per essere ancora più precisi, essa
è il modo del pensiero, è un’idea, una nozione, che a sua volta risponde a un
modo particolare dell’attributo estensionale di Dio, che è tutto quanto il corpo.
Dato che
l’essere umano consiste in una mente (un modo del pensiero) e in un corpo (un
modo dell’estensione), egli è il soggetto sia di ‘percezioni’ (o forme di
conoscenza) sia di passioni. A differenti passioni si accompagnano, per natura,
differenti forme di conoscenza. E, come aveva già fatto per le percezioni nel Trattato dell’emendazione
dell’intelletto, Spinoza
distingue tra: opinioni acquisite grazie a racconti altrui o a esperienze
accidentali, credenze vere acquisite grazie all’arte del ragionamento, e (il
massimo) comprensione intuitiva della cosa stessa grazie a un concetto chiaro e
distinto. A differenza della conoscenza indiretta e dell’esperienza
accidentale, il sapere razionale, ottenuto sia per deduzione sia per intuizione
immediata, non è soggetto a errori.
E uno stato cognitivo stabile, che permette di afferrare l’essenza dell’oggetto. Migliore è l’oggetto e migliore sarà la conoscenza; migliore è la conoscenza e migliore sarà la condizione di colui che conosce. ‘Il più perfetto è quindi quell’uomo, proclama Spinoza, che si unisce a Dio (che è l’essere perfettissimo) e di lui così gode’.
Queste
diverse forme di percezione hanno tutte i loro specifici riflessi affettivi. Spinoza cataloga, analizza e valuta con
cura le diverse passioni cui è soggetto l’essere umano, amore, gioia, odio,
tristezza, invidia, vergogna, desiderio, gratitudine, rimorso, e via dicendo, e
dimostra quali di esse portino alla felicità e quali invece conducano alla
nostra rovina.
Fino a
quando noi facciamo affidamento sui racconti altrui o sulle nostre passate
esperienze accidentali, giudicando e rincorrendo solo gli oggetti sfuggenti
dell’immaginazione e dei sensi, restiamo dominati da passioni quali il
desiderio, l’odio, l’amore, la tristezza lo stupore, il piacere, la paura, la
disperazione e la speranza. Le cose corruttibili sono infatti completamente al
di fuori del nostro controllo. Né abbiamo alcuna presa su di esse, e tanto le
loro proprietà quanto il loro possesso possono sempre sfuggirci di mano.
Questo tipo
d’amore e di attaccamento per le cose materiali può condurre solo alla rovina.
La credenza
vera, invece, porta progressivamente a una chiara comprensione dell’ordine
dell’universo e permette di capire come gli oggetti esterni dipendano realmente
dalla loro origine e causa ultima. In questo modo possiamo riuscire infine a
conoscere Dio stesso e le ‘cose eterne e incorruttibili’ che dipendono
direttamente da Dio, nonché il modo in cui le cose corruttibili dipendono da
quelle.
La conoscenza di Dio non è altro che la conoscenza della Natura in ogni suo aspetto. E questa conoscenza conduce all’Amore dell’esser sommo, da cui tutto dipende. Solo grazie a tale conoscenza, infatti, noi possiamo agire senza venire travolti da passioni come l’odio e l’invidia, che si basano sulla formulazione di giudizi falsi e scorretti sugli oggetti o sulla mancata percezione della loro necessità.
È l’uso
appropriato della ragione che ci consente di estirpare queste passioni dalle
nostre vite. Ed è questo che ci consente al tempo stesso di contemplare
l’essere immutabile.
‘Se l’uomo giunge ad amare Dio, che è e resta
immutabile, per lui è impossibile cadere in questa melma delle passioni. E
perciò stabiliamo, come regola fissa e immutabile, che Dio è la prima e unica
causa di ogni nostro bene e colui che ci libera da ogni nostro male’.
Giunti a
questo punto, capiamo che l’uomo fa parte della natura ed è indissolubilmente
vincolato all’ordine (apparentemente) causale delle cose. Anche noi siamo
infatti determinati nelle nostre azioni e passioni. E la libertà, intesa come
spontaneità, è una semplice illusione. ‘Poiché l’uomo è una parte di tutta la
natura, da cui dipende e da cui anche è governato, non può fare nulla da se
stesso per la propria salute e il proprio bene’.
Noi dobbiamo
dunque capire che il nostro corpo, e tramite esso la nostra mente, è soggetto
alle stesse leggi di natura che governano ogni altra cosa.
‘Noi dipendiamo a tal punto da ciò che è
sommamente perfetto che siamo anche come una parte del tutto, cioè di lui
[Dio], e contribuiamo, per così dire, alla produzione di tante opere bene
ordinate e perfette, che da lui dipendono’. Sapere questo ci libera dalla
tristezza, dalla disperazione, dall’invidia, dalla paura, e da altre cattive
passioni, le quali… sono il vero e puro inferno.
Soprattutto, noi dobbiamo smettere di temere Dio, che è lo stesso bene supremo, a causa del quale sono ciò che sono tutte le cose che hanno qualche essenza, e anche noi, che viviamo in lui. Questa è la via verso il bene e la felicità. La conoscenza e l’amore di Dio, indebolendo il potere che il corpo ha su di noi, possono liberarci da tutti i malesseri creati dalle passioni e possono al tempo stesso incrementare la nostra vera libertà intesa come esistenza stabile che il nostro intelletto acquisisce grazie all’unione immediata con Dio e come svincolamento dalle cause esterne e in ciò consiste la nostra beatitudine’.
Nonostante
il linguaggio teologico impiegato da Spinoza,
e alcune apparenti concessioni agli ortodossi (‘l’Amore di Dio è la nostra
massima beatitudine’), non ci possono essere equivoci sulle sue intenzioni, il
suo scopo è nientemeno che la completa desacralizzazione e naturalizzazione della
religione e dei suoi concetti:
‘L’uomo, finché è una parte della
natura, deve seguire le leggi della Natura: questa è la vera religione, e
finché egli agisce così permane nel bene’.
Il Breve
trattato è un’opera difficile e complessa, Spinoza
spese molte energie nel rivederne e chiarirne la forma e il contenuto, forse
mostrò alcune parti di una copia dell’ultimo manoscritto in latino a Oldenburg,
quando questi sostò a Rijnsburg nell’estate
del 1661, ma sembra comunque che sia stato piuttosto cauto nel rivelarne i
dettagli all’ospite: Oldenburg ricorda infatti che ‘si è parlato tra di noi
come attraverso una grata’.
In una
lettera a Blijenburgh degli inizi del
1665, egli dichiara in tal senso che ‘dell’opera su Cartesio non mi sono
più occupato ulteriormente dopo la sua pubblicazione in olandese’. I motivi,
aggiunge, ‘sarebbero troppo lunghi da enumerare’.
(S. Nadler)
UNA PASSEGGIATA NEL GIARDINO OLANDESE (le campanelle bianche di Febbraio, evento assai raro, scorrono vicino ad un Fiume Nero…)
Indubbiamente
la strada per raggiungere i Bulb Gardens of Holland è seguire la strada
attraverso la quale i bulbi arrivano in Inghilterra (assieme alla posta con cui talora anche il Filosofo si misurava con
una cartesiano). O almeno seguono quella strada in una certa misura: i
bulbi di solito compiono parte del viaggio nell’entroterra del loro paese in barca
sui canali, un procedimento né molto possibile né molto comodo per il
viaggiatore medio. Ma per il resto il loro percorso è quello adatto a chi ha
svago e vuole arrivare ai giardini nel modo più adatto.
Si sale su
un piccolo piroscafo olandese alle Scale della Torre, un piroscafo che sembra
avere una gran fretta di partire, ma non lo è mai, anche se tutti e tutto,
compresa la fuga del vapore, sono molto occupati finché finalmente non strilla
sotto il Tower Bridge e quindi lungo il fiume. Questi piroscafi a volte lo sono
vengono chiamate con disprezzo navi mercantili, e certamente i bulbi, nelle
loro scatole da imballaggio bianche e pulite, arrivano in Inghilterra in quel
modo; e quando non vengono, prendono il loro posto formaggi olandesi in quantità
e altre cose.
Ma la
sistemazione dei passeggeri ha molti aspetti da consigliare. Ricordo una grande
cabina sul ponte, molto più grande e leggera di gran parte delle sistemazioni
di prima classe delle grandi navi di linea indiane e australiane. Ricordo lenzuola
di robusto lino di campagna, che ricordano nel loro profumo di asperula le
casse di mogano spagnole dove le massaie riponevano i loro attrezzi con l’erba
aromatica. Ricordo un posto accogliente con una lampada oscillante e
armadietti, che ricordava più la cabina della Goletta Hesperus, quando lo
skipper aveva portato la sua figlioletta a fargli compagnia, che il salone di
un piroscafo che attraversava la Manica.
È vero che il cibo è olandese, ma se, come non di rado accade, si è passeggeri unici, lo si mangia quando e dove si vuole, il che è un compenso. È anche vero che a bordo non c’è nessuna hostess, e spesso non c’è qualcuno che parli bene l’inglese, e che il viaggio dura piuttosto lungo, ma queste sono sciocchezze.
La virtù
nazionale dell’Olanda, l’Olanda che si vede dal canale, è l’industria; non
esattamente energia, certamente non ‘trambusto’ o qualcosa di simile, ma
industria, unita a una pulizia che mantiene in ordine anche i fossati e non
consente quel diritto inalienabile dell'abitante rurale inglese, il mucchio di
spazzatura del giardino. Gli olandesi sembrano i più industriosi di qualsiasi
altra cosa al mondo, a parte forse le formiche, con una comunità alla quale,
bisogna ammetterlo, hanno qualche somiglianza. L’ideale nazionale, almeno nel
distretto dei bulbi, è la pulizia.
La lode più
alta da tributare a qualsiasi cosa è che sia pulita. Un bel bulbo di tulipano
nella sua brillante buccia giallo-marrone viene esaltato come “così pulito”;
del curioso terreno sabbioso in cui crescono i bulbi si parla con orgoglio come
sempre pulito; il grande complimento da fare a una stalla a bulbo è che è
pulita. Forse uno dei vantaggi del lavoro dei coltivatori è che è pulito.
Credo che
sia consuetudine parlare di Amsterdam come della Venezia del Nord, per chi non
ha visto Venezia è impossibile fare un paragone, ma sembra difficile immaginare
molta somiglianza tra loro, al di là del fatto che entrambe possiedono canali,
case e storia. Amsterdam ricorda in qualche modo i romanzi di Dickens, è
immensamente interessante, piuttosto affollata, reale, indaffarata, familiare e
genuina; non evoca esattamente passioni devastanti o alto romanticismo, ma pace
confortevole e salutare.
Nei giardini dei bulbi non c’è molto da fare in inverno, almeno durante le gelate. La terra viene messa a letto, la maggior parte dei campi di bulbi sono ricoperti di paglia o di canne, solo quelli che contengono le specie più resistenti, come la Scilla sibirica , l’Aconito invernale e poche altre, vengono lasciati nudi. Questa copertura, che è di spessore variabile per adattarsi ai bulbi sottostanti, non viene spostata finché non scoppia il gelo e inizia il clima più mite. Ma quando ciò accade c’è molto da fare, perché deve essere spostata secondo il salita e discesa del termometro: parzialmente rimosso se il clima si mantiene mite, altrimenti i bulbi si svilupperebbero troppo velocemente con il caldo sottostante; sostituito per le notti fredde o se è probabile un forte gelo.
All’inizio
della primavera bisogna prestare molta attenzione a questo, perché con
mezzogiorno soleggiato, forti gelate notturne, periodi di prolungata pioggia
battente e improvvisi venti pungenti, è molto difficile proteggere
adeguatamente e non coprire eccessivamente i bulbi.
I crochi non sono molto coltivati nelle immediate vicinanze di Haarlem, la terra è troppo preziosa per essere dedicata all’economico bulbo. Molte migliaia vengono da Hille, alcuni piccoli coltivatori ne fanno una specialità e coltivano poco altro; sono loro che riforniscono i grandi uomini che riforniscono i mercati. Sembra che ci siano ora circa ottantatré specie di croco, il che è qualcosa in più rispetto alle sei specie che ‘Robinio di Parigi, quel doloroso e curioso ricercatore di semplici’, inviò a Gerardo. Al tempo di Parkinson sembra che se ne conoscessero trentuno specie, ma ai suoi tempi avevano cominciato a coltivare seriamente i bulbi, e per loro sarebbe stato più un motivo di interesse che di sorpresa vedere le nostre varietà, le quali, secondo l’autorità del coltivatore, si dice, ‘sono state derivato da (coltivato dal seme del) originale Crocus vernus dell’Europa meridionale e centrale.
Quando
questo croco venne introdotto per la prima volta in Olanda non è facile dirlo.
Né è facile scoprire “quando” (nelle parole dello stesso coltivatore)
“coltivatori e dilettanti cominciarono a ibridare le diverse forme” – né quando
per la prima volta vi furono diverse forme da ibridare; certamente lo è
successo molto tempo fa. Si racconta che il croco dello zafferano (Crocus
sativus) sia stato introdotto in Inghilterra nel 1339.
Hakluyt
racconta che fu portato da un pellegrino che, apprezzando il valore sovrano
della pianta, e ‘proponendosi di fare del bene al suo paese’, portò a casa una
radice nascosta nel suo bastone, che era stato reso cavo ‘allo scopo’, anche se
non è chiaro se allo scopo di trasportare zafferano o qualsiasi altra cosa di
valore o interesse che potesse raccogliere. In entrambi i casi il procedimento
è piuttosto tipicamente inglese, così come lo sono anche le ulteriori osservazioni
di Hakluyt sulla coltivazione dello zafferano. Si rammarica che sia diventata
un’industria in declino in questi giorni, quando molti individui robusti sono
senza lavoro, e suggerisce, proprio come noi suggeriamo la rinascita di varie
cose curiose, che dovrebbe essere rilanciata a beneficio dei disoccupati, che
poi, come adesso, fossero un problema di tipo taglia e torna.
Si ritiene ora che il croco originale di tutti i crochi fosse originario del Kashmere e abbia seguito la migrazione ariana attraverso il globo temperato; portato, senza dubbio, in primo luogo per il suo zafferano, di cui sembra che questi remoti antenati della razza europea avessero la stessa stima del pellegrino di Hakluyt. Nelle sue varie forme selvatiche lo si trova ora in Persia e nel Levante, nelle Alpi e negli Appennini, in Italia e in Grecia, e sui pendii inferiori dei Pirenei; ed è passato così tanto tempo in questi paesi che è stato considerato un fiore autoctono e ha un posto in molte antiche leggende. Ovidio racconta che Proserpina stava raccogliendo ‘graziosi crochi e gigli bianchi’ quando fu rapita. È lui anche a raccontare l’origine del fiore in Grecia. Un giovane di nome Croco innamorato della ninfa Smilace: egli, per l’impazienza del suo amore, si trasformò nella fiore; e lei, senza una ragione apparente, che sembra ingiusta, si trasformò non nella delicata pianta verde che chiamiamo con il suo nome, ma in un albero di tasso, un destino un po’ cupo per l’innamorata di un insignificante effimero come appare Crocus.
Nonostante
questa storia d’amore impaziente non sembra esserci alcuna traccia, come ci si
potrebbe aspettare, dell’uso del croco nell’aroma di filtri o amuleti d’amore.
Il velo dell’Imene era color zafferano; il fiore, tra gli altri, sbocciò sul
terreno dove giacevano Zeus ed Era, per puro stupore, si potrebbe immaginare,
nel vedere la coppia olimpica in buoni rapporti. Noi stessi lo abbiamo dedicato
a San Valentino -
Mentre il croco si affretta al santuario
Dell’amore di Primula a San Valentino
È stato utilizzato per molte altre cose. ‘Il croco raggiato d’oro’ è tra i fiori che incoronano la ‘potente dea’ di Sofocle. Sappiamo che anche i Greci lo annoveravano tra i profumi. Aristofane, ne Le Nuvole. Presso gli orientali era considerata una spezia scelta: ‘Nardo e zafferano, calamo e cannella, con tutti gli alberi d'incenso, mirra e aloe’, erano le spezie che dovevano uscire dal giardino dell’Amato nel Cantico dei Cantici. Un’antica autorità lo riteneva il cibo delle fate, e gli umani del suo tempo lo tenevano in grande considerazione. Ma ora è caduto dal suo alto rango, e, anche se il Consiglio della Contea o qualche altro organismo potesse ancora perseguire un uomo per aver venduto zafferano adulterato, sarebbe filantropia disinteressata e non avrebbe alcuna somiglianza con il rogo dei delinquenti a Norimberga nel quindicesimo secolo per un reato simile.
In Persia è
ancora molto utilizzato come condimento, in misura minore in Spagna, in Olanda
lo si trova ad aromatizzare il riso bollito con il latte; qui in Inghilterra
persiste ancora nelle torte allo zafferano della Cornovaglia, altrimenti gioca
un ruolo marginale, tranne che come colorante alimentare. Sembra che fosse in
uso ai tempi di Shakespeare. Il clown, che ha così tante cose da comprare per
la festa della tosatura di Perdita, la spunta tra le altre: ‘Devo avere dello
zafferano’, dice, ‘per colorare le torte del guardiano’.
E noi, anche se abbiamo perso lo scontrino per le torte del guardiano, usiamo ancora lo zafferano per colorare la nostra cucina. Questo è particolarmente vero in Russia, dove la legge stabilisce che tutti i coloranti alimentari devono essere vegetali, una legge singolare, se si pensa che tutti i veleni alcaloidi sono di origine vegetale, e per la loro vera cattiveria è difficile da battere alcuni dei coloranti forniti dalla Natura.
Infine, per concludere questa breve passeggiata di Domenica, a tutti coloro che in quest’hora ridono con diverso zafferano condire il proprio ed altrui riso per il misfatto compiuto, circa l’ideale tradito della Natura sancita ‘dal e nel’ Diritto, raccomandiamo una diversa passeggiata così come non udire o ammirare i Fiori del nostro Eterno Giardino!
EPILOGO
Per la
maggior parte del tempo lottiamo non con la realtà, ma con le sue rappresentazioni
matematiche (come abbiamo appena letto fra Spinoza e Cartesio e un successivo
inglese).
La mistica
della matematica, la fede che la realtà possa essere colta nel suo livello più
profondo attraverso un’equazione o una costruzione geometrica: ecco la religione
privata e intima del fisico teorico. Come ogni altra vera mistica non può
essere comunicata a parole: ne occorre l’esperienza. Occorre poter sentire, al
di là delle parole, la possibilità che uno dei pezzi della matematica che si
arriva a comprendere possa essere anche una rappresentazione del mondo.
Sospetto
fortemente che questa gioia di scoprire all’interno della propria mente una
corrispondenza fra una costruzione matematica e un oggetto della natura sia una
esperienza che i matematici e i fisici
più attivi devono aver provato. La si può provare in un momento di
illuminazione che ci fa comprendere le leggi di Newton e che al tempo stesso ci
fa capire di aver afferrato la logica che si realizza nel moto di infinite cose
esistenti. È per questi motivi che la formazione di un fisico o di un
matematico assomiglia un po’ all’ingresso di un novizio in un ordine religioso
misticheggiante. Naturalmente, col progredire dello studio, ci si accorge ben
presto che né le leggi di Newton né la geometria euclidea colgono
effettivamente la realtà del mondo.
Ciò che è al contempo meraviglioso e terrificante in tutto questo è che non c’è assolutamente alcun motivo per cui la natura nei suoi aspetti più profondi dovrebbe avere qualcosa a che fare con la matematica. Non c’è da invocare nessun mistero, nessuna nascosta simmetria per spiegare perché l’aria si diffonda uniformemente in una stanza. Ogni atomo si muove casualmente, è semplice statistica dei grandi numeri. Il peggiore incubo del platonista è forse quello di scoprire che tutte le nostre leggi sono come queste, di scoprire che tutte le belle regolarità che abbiamo scoperto si possono rivelare nient’altro che regolarità statistiche, dietro le quali si cela solo il caso o l’irrazionalità.
È questo,
forse, uno dei motivi per cui la biologia sembra costituire un problema per
alcuni fisici. La possibilità che la sconvolgente bellezza del mondo vivente
possa, in definitiva, essere fatta risalire solo al caso, alla statistica, al
mero accidente, rappresenta una vera e propria minaccia per la concezione
mistica che vorrebbe che la realtà possa venir catturata in un’unica, elegante,
bella equazione.
È per
questo motivo che mi ci sono voluti degli anni prima di potermi adattare
all’idea che le leggi della fisica, almeno in parte, potrebbero venir spiegate
proprio attraverso questa stessa logica del caso. In questo breve post ci
occupiamo del problema di come costruire una teoria dell’intero universo.
Ma il caso
cosmologico è assai diverso.
Ogni soluzione dell’equazione universale descrive un intero mondo, ma solo una di esse può avere qualcosa a che fare con la realtà del nostro. Questo significa che una qualsiasi teoria dell’intero universo, se è un gioco newtoniano, deve presentarsi con un’appendice che ci dica quale fra le infinite soluzioni descrive l’universo reale. Questo è il cosiddetto problema delle condizioni iniziali. È un problema che riguarda la cosmologia, visto che implica che ci debba essere un qualche motivo perché l’universo sia iniziato in un certo stato piuttosto che in un altro.
Ma se questa ragione giace fuori dall’universo, sembrerebbe seguirne che l’universo non è tutto ciò che esiste, il che è contraddittorio perché allora non sarebbe l’universo. C’è quindi il pericolo che il bisogno di una tale teoria legata alle condizioni iniziali faccia rientrare la religione dalla finestra. Religione che non sarebbe però il misticismo matematico di cui abbiamo parlato, ma l’idea che esista un Dio che consapevolmente ha deciso e scelto di fabbricare il mondo. Si dice che Einstein abbia detto una volta: ‘Ciò che mi piacerebbe veramente sapere è se Dio ha avuto una qualche scelta quando ha creato il mondo’.
Il problema
delle condizioni iniziali in cosmologia non è stato ancora risolto.
Al giorno
d’oggi viene usualmente paludato nel linguaggio della fisica quantistica, dove
diventa il problema di specificare lo stato quantistico dell’universo. Di
quando in quando qualcuno viene fuori a sostenere che dovrebbe esistere una
soluzione unica delle equazioni della cosmologia quantistica. Ma, ogni volta,
un più attento esame rivela che quelle equazioni ammettono molte soluzioni,
ciascuna delle quali descrive una cosmologia possibile.
Il problema cui ci troviamo di fronte è il seguente: la fisica fondamentale e la cosmologia devono assomigliare, nel loro utilizzo dei numeri, alla matematica pura o alla biologia?
Se
l’universo intero non fosse altro che l’opera di leggi deterministiche, il
futuro risulterebbe in senso stretto una manifestazione del presente. Non c’è
un domani in cui potrebbe accadere qualcosa di nuovo, un qualcosa che non sia
già codificato nell’oggi. È la concezione platonista di teoria fisica che rende
difficile, in generale, credere nella possibilità della novità.
Tutte le
strutture del mondo sono riflessi di forme ideali, e dunque non ci può essere
nulla di nuovo: le forme sono eterne. Il mondo biologico sembrerebbe smentire
questa concezione, visto che la storia della selezione naturale è piena di
momenti in cui sono state inventate nuove forme prima inesistenti.
La
tentazione di asserire che in biologia la novità è possibile è molto forte. Ma
se crediamo che le leggi fondamentali siano deterministiche, ci possiamo
veramente permettere di credere nella realtà del nuovo, o dobbiamo continuare a
insistere sull’impossibilità della novità?
Sembra che siamo di fronte a un problema che vale la pena di esaminare: come è possibile che processi descritti completamente da leggi fisiche possano creare cose che non esistevano in tempi precedenti?
E come
cambierebbe la risposta da dare a questa domanda, se le leggi della fisica
fossero esse stesse il risultato di un processo di autorganizzazione o di
selezione naturale?
I
processi naturali, agendo nel tempo, possono effettivamente creare il nuovo. Ma
c’è però un problema filosofico o, per dirla meglio, un problema per la
filosofia.
Si suppone
che il processo di selezione naturale sia semplicemente opera della logica e
della probabilità che agiscono su processi che riguardano molecole strutturate.
E la probabilità non dovrebbe essere altro che una forma di contare, e anche il
contare, ci dicono i logici, non è altro che logica.
In
definitiva, dunque, la selezione naturale non è altro che l’opera dei principi
della logica applicati a certe popolazioni di molecole strutturate. Ma la
logica dovrebbe essere tautologica. E in una tautologica non dovrebbe esserci
alcuna informazione reale, perché il suo significato è di essere vera in ogni
circostanza possibile. Ma se qualcosa è vero in ogni circostanza possibile, è
vero sempre. E dunque non ci può mai essere niente di nuovo.
Come è
dunque possibile che una cosa che non comporta nient’altro che l’opera della
logica della probabilità riesca a generare il nuovo?
Il problema di come sia possibile la novità è dunque un problema per la filosofia. Una risposta possibile è che nella realtà la novità non esiste. La possibilità di ogni specie, anzi, di ogni possibile miscuglio di specie, esiste non appena esista il meccanismo fondamentale della vita. Ma si deve intendere la selezione naturale come qualcosa che ha luogo nel tempo; di conseguenza le proprietà di una specie saranno anch’esse giudizi dipendenti dal tempo che valgono solo durante il periodo di tempo necessariamente limitato che corrisponde alla vita della specie stessa.
Se la
logica pura sembra non avere alcun potere di creazione quando viene considerata
nel contesto di un mondo statico, platonico, fatto di proposizioni che sono
vere o false per l’eternità, un processo che agisce nel tempo per trasformare
le strutture dell’universo, quale è quello della selezione naturale, può essere
al contempo compiutamente spiegabile in termini logici ed essere veramente
capace di inventare il nuovo.
Sottolineando che esistere deve significare esistere nel tempo, possiamo
rovesciare la trappola che la vecchia metafisica ci aveva imposto: quella per
cui ciò che realmente esiste, l’Essere, può esistere solo eternamente, mentre
le cose che esistono nel tempo sono solo apparenze, solo pallidi riflessi di
ciò che è realmente reale.
Se l’esistenza ha bisogno del tempo, allora non c’è né bisogno né posto per l’Essere, per il mondo platonico assoluto e trascendente. Ciò che esiste è ciò che troviamo nel mondo. E ciò che esiste, esiste nel tempo, perché per esistere deve essere creato da processi che agiscono nel tempo per creare il nuovo e l’inatteso da ciò che precedentemente esisteva Questo semplice scherzo, che suggerisce come la nozione di struttura nel mondo si sia formata attraverso la selezione naturale, ci permette di evadere dalla prigione platonica in cui è costretta a languire l’epistemologia. In particolare, quella visione del mondo ci impone di aspettarci che la conoscenza oggettiva – la conoscenza del reale è anch’essa una conoscenza che vive nel tempo.
Il problema
tuttavia persiste, almeno ad un livello puramente teorico: se il mondo non è
altro che l’opera di una legge matematica preesistente, come è possibile la
novità?
La
possibilità che le leggi possano anche non essere eterne, ma che possano
effettivamente essere costruite nel tempo per mezzo di processi fisici getta
una nuova luce su questo dilemma. I due diversi tipi di matematica su cui può
essere fondata la fisica fondamentale discendono da due diversi concetti di
forma e di come le forme possono essere state generate.
Pensiamo,
ad esempio, a un fiore e a un
dodecaedro.
Sono entrambi belli, entrambi ordinati, e il fiore potrebbe anche non sembrare meno simmetrico di quella costruzione geometrica. La differenza fra loro, sta, appunto, proprio nel modo in cui sono stati costruiti. Il dodecaedro è una manifestazione esatta di un certo gruppo di simmetrie, che può essere descritto in una riga di simboli matematici. E anche se non posso costruirne uno perfetto, posso però fabbricarne un’ottima rappresentazione, con carta, forbici e colla o anche con programmino per un calcolatore.
Un fiore, per contro, non è
perfetto, se lo esaminiamo da vicino, vedremo che, nonostante possa apparire
simmetrico, non aderisce precisamente a nessuna forma ideale. Dall’avvolgimento
del suo DNA in ciascuna delle migliaia di miliardi delle sue cellule, fino alla
disposizione dei suoi petali, la forma di un fiore potrà spesso suggerire una
simmetria, ma non riuscirà mai a realizzarla
precisamente. Ma con tutte queste sue imperfezioni, non c’è modo in cui io
possa costruire un fiore. Esso è il prodotto di un vastissimo sistema che si
estende assai lontano nelle profondità del tempo.
La sua
bellezza è il risultato di miliardi di anni di incrementi evolutivi infinitesimali,
dell’accumularsi di scoperte operate da ciechi processi statistici; il suo
significato sta nel ruolo che gioca in un ecosistema molto più grande di lui,
in cui è coinvolta l’esistenza di tanti e tanti altri organismi viventi. Gli
antichi greci, come i fisici che portarono a compimento la rivoluzione
copernicana non conoscevano nulla della possibilità che la struttura si formi
attraverso simili processi. Non avevano altra alternativa per spiegare la
bellezza e l’ordine del mondo se non vagheggiare che esso rappresentasse un
riflesso dell’eterna forma matematica di Platone.
Il problema
che ci troviamo oggi di fronte è se la nostra teoria fisica rimarrà limitata da
questa concezione o se invece vorremo usufruire dei vantaggi resi possibili
dalla costruzione di un mondo ordinato attraverso processi di
autorganizzazione.
Il
problema, in ultima analisi, si riduce a questo: se l’universo assomiglia a un
fiore o a un dodecaedro.
(L.
Smolin, La vita del cosmo; da G. Lazzari L’Eretico Viaggio)










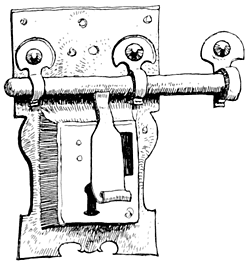
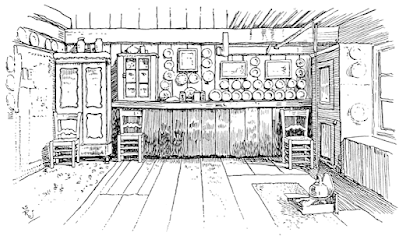




















Nessun commento:
Posta un commento