Precedenti capitoli
circa un Discorso
d'apertura (15/7)
Prosegue con il...:
& con la corruzione (19)
Gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso sono quelli della Guerra fredda tra il blocco occidentale – Stati Uniti ed Europa – e il blocco sovietico, una guerra che russi e americani combattono sperimentando armi nucleari sempre più distruttive e sviluppando missili in grado di portarle sul nemico scavalcando gli oceani. Negli arsenali si accumulavano migliaia di bombe atomiche con un potenziale tale da distruggere il pianeta in pochi minuti. I test nucleari nell’atmosfera erano all’ordine del giorno.
Il 12 settembre 1962, proponendo la conquista della Luna come ‘nuova frontiera’ degli Stati Uniti, con un discorso di 17 minuti e 48 secondi all’Università Rice il presidente Kennedy spostò la Guerra fredda tra blocco occidentale e blocco sovietico su di un piano simbolico. Portare la sfida nello spazio significava trasformare la rivalità tra le superpotenze in una competizione dal sapore quasi sportivo. La forza militare si dava un obiettivo di progresso anziché di sopraffazione. In termini etologici, lo scontro fisico diventava uno scontro stilizzato: come i camosci quando si incornano senza farsi troppo male, basta che sia chiaro chi ha diritto alla femmina più ambita.
La dissoluzione dell’Unione Sovietica fu in parte una conseguenza della supremazia spaziale conquistata dagli Stati Uniti con il Programma Apollo. Decisiva nel 1989 fu la caduta del muro di Berlino. Ne derivò un nuovo equilibrio mondiale che soltanto ora, con l’ascesa di Trump negli Stati Uniti, il dominio assoluto di Putin in Russia, la potenza cinese e la debolezza dell’Europa – di nuovo corrosa da stolti nazionalismi –, si sta incrinando.
Partita in
forte vantaggio con il lancio del primo satellite artificiale, il 4 ottobre 1957, e con il primo uomo
in orbita, Jurij Gagarin, il 12 aprile 1961, l’Unione Sovietica
perse la guerra simbolica dello spazio. Il
3 luglio 1969, mentre Armstrong,
Aldrin e Collins stavano per decollare verso il Mare della Tranquillità, il
gigantesco razzo N-1 che Sergej Korolëv
aveva progettato per lo sbarco sovietico esplodeva sulla rampa di lancio, e in
una gara come quella non c’era posto per il secondo arrivato.
La conseguenza,
imprevista anche dal governo americano, fu il tramonto della Guerra fredda e
l’inizio della collaborazione nelle attività spaziali, sancita dalla missione
congiunta Apollo-Sojuz del luglio 1975
e tuttora garantita dalla Stazione spaziale internazionale, che orbita sulle
nostre teste con le bandiere di Usa, Russia, Unione Europea, Canada e Giappone.
Visto così, lo sbarco sulla Luna diventa una vittoria della Ragione. Gli
astronauti russi e americani sono gli Orazi e Curiazi del nostro tempo.
Certo va messo all’attivo l’impulso allo sviluppo tecnologico, un’onda lunga che porta alla navigazione satellitare, a Internet, ai telefoni cellulari, all’Intelligenza Artificiale. Ma forse ancora più importante è che volando verso la Luna l’uomo vide la Terra in tutta la sua bellezza e (violata) fragilità. Da allora siamo consapevoli di vivere su un’astronave naturale che corre intorno al Sole alla velocità di 30 chilometri al secondo: una nicchia ecologica con risorse limitate ed equilibri instabili. L’uomo, animale esploratore, andando per la prima volta su un altro mondo, scopriva il proprio.
Il 12 settembre 1962 Kennedy presentò al mondo il progetto di conquista della Luna con
queste parole, pronunciate allo stadio della Rice:
‘Non vi è alcun contrasto, nessun preconcetto,
nessun conflitto nazionale nello spazio. I suoi rischi lo rendono a tutti
ostile.
La sua conquista merita il meglio di tutta
l’umanità.
Certe opportunità di cooperazione pacifica
potrebbero non ripresentarsi.
Ma perché, qualcuno dirà, la Luna?
Perché preferire questo come nostro obiettivo?
E costoro potrebbero allora domandarsi a buon
diritto perché scalare le montagne più alte?
Perché, trentacinque anni fa, trasvolare l’Atlantico?
Perché la Rice gioca con la Texas?
Noi scegliamo di andare sulla Luna. Noi scegliamo
di andare sulla Luna entro questo decennio non perché sia facile ma perché è
difficile, perché quell’obiettivo ci servirà a organizzare e misurare le nostre
migliori energie e capacità, poiché questa è una sfida che siamo disposti ad
accettare, non siamo disposti a rimandare una sfida che intendiamo vincere. È
per queste ragioni che io ritengo la decisione di rendere prioritaria la
conquista dello spazio, tra le più importanti della mia presidenza’.
Risulta che
Kennedy, a grandi linee, avesse
concordato con i suoi consiglieri il discorso della ‘nuova
frontiera’, ma che lo sbarco sulla Luna dovesse avvenire ‘entro questo decennio’ sembrò aggiunto nella foga
oratoria del momento. Quando sentirono quella frase, i tecnici del suo staff
ebbero un brivido di sgomento e dopo il bagno di folla segnalarono al
presidente l’imprudenza.
Ma il sogno
di inviare un americano sulla Luna Kennedy
lo aveva già comunicato al Congresso il
25 maggio 1961. In quei giorni la Nasa aveva fatto arrivare al
vicepresidente Johnson il sospetto che l’Unione Sovietica, dopo il successo di
Gagarin in orbita, stesse preparando lo sbarco sulla Luna per il 1967, cinquantenario della
Rivoluzione di ottobre.
Kennedy, allora, pensò a quell’anno anche per il
programma spaziale americano. Alla Nasa si diffuse il panico. All’inizio degli anni Sessanta, lo
svantaggio rispetto all’Unione Sovietica era troppo grande. Robert Seamans,
codirettore della Nasa, telefonò al consulente di Kennedy, Ted Sorensen, spiegandogli che non ci si poteva esporre per quella
data. ‘Allora che cosa consigliate?’ domandò Sorensen, e Seamans suggerì di dire ‘entro il decennio’.
Le parole di Kennedy furono:
‘Io penso che questo paese possa darsi un
traguardo e raggiungerlo: far scendere un uomo sulla Luna e riportarlo sano e
salvo sulla Terra prima che questo decennio sia finito’.
In realtà nessuno credeva che fosse un obiettivo raggiungibile. Capita che parole avventate trasformino in realtà sogni improbabili.
(P. Bianucci)
La sua infanzia era stata affamata e randagia, ma l’infanzia è la stagione più felice della vita.
Particolarmente sereno era stato l’inizio della
primavera – le giornate di maggio fuori città. Il profumo di terra e d’erba
tenera riempiva l’anima di gioia. La sensazione di felicità era penetrante,
addirittura insostenibile, a volte lei era così felice da non sentire neppure
la fame. Per tutto il giorno le aleggiava nella testa e negli occhi una tiepida
foschia verde. Si abbassava sulle zampe anteriori davanti a un soffione,
abbaiava a scatti con allegra e impaziente voce infantile, invitando il fiore a
scorrazzare con lei, ora indispettita ora beffarda, sorpresa dell’immobilità
del suo grosso gambo verde.
Poi all’improvviso cominciava a scavare
freneticamente una buca, e le zolle volavano via da sotto il suo pancino, le
zampe pezzate, rosee e nere, e i piccoli polpastrelli scottavano a forza di
sfregare la terra sassosa. Il suo musetto assumeva un’espressione febbrile come
se, invece di giocare, la cagnetta si stesse scavando un rifugio per salvarsi
la vita.
Era paffuta, aveva la pancia rosea, le zampe
grosse, malgrado mangiasse poco in quel tempo radioso. Pareva che ingrassasse
per la felicità, per la gioia di essere viva.
Ma poi erano finiti i giorni lievi dell’infanzia. Il mondo si era riempito di ottobre e di novembre, di ostilità e di indifferenza, di pioggia ghiacciata mista a neve, di fango, di avanzi viscidi, così ripugnanti da nauseare persino un cane affamato.
Ma anche nella sua esistenza errabonda accadeva
qualcosa di buono – lo sguardo compassionevole di un essere umano, la
possibilità di passare la notte accanto a una tubatura calda, un osso
appetitoso. La sua vita canina aveva conosciuto la passione, l’amore e la luce
della maternità.
Era una bastardina piccola, con le zampe storte. Ma
sapeva eludere le forze ostili perché amava la vita ed era molto intelligente.
Quella cagnetta dalla fronte ampia sapeva dove si annida il pericolo, sapeva
che la morte non fa chiasso, non si sbraccia in gesti minacciosi, non scaglia
pietre, non prende a calci con gli stivali, ma porge un pezzo di pane e si
avvicina con un sorriso subdolo, nascondendo dietro la schiena una rete di tela
ruvida.
Conosceva la forza distruttiva di camion e automobili, ne sapeva valutare esattamente la velocità, era capace di attendere con pazienza il defluire del traffico e di attraversare la strada di gran carriera davanti alle auto ferme al semaforo. Conosceva il treno, devastante nel suo avanzare rettilineo, e inoffensivo come un bambino per la sua incapacità di far male persino a un topo ad appena mezzo metro dalle rotaie. Distingueva il rombo, il fischio, il fragore degli aerei a elica e di quelli a reazione, il frastuono ritmico degli elicotteri. Conosceva l’odore dei tubi del gas, era capace di individuare il calore emanato dalle tubature sotterranee delle centrali termiche. Conosceva i ritmi di lavoro dei camion della nettezza urbana, sapeva come penetrare nei bidoni e nei cassonetti della spazzatura, distingueva all’istante l’involucro di cellofan dei prodotti semilavorati di carne e quello cerato del merluzzo, del gelato alla crema e del persico di mare.
Un cavo elettrico nero che sbucava da sottoterra la
terrorizzava più di una vipera – una volta, con una zampa bagnata, ne aveva
sfiorato uno, isolato in modo difettoso.
Probabilmente la cagnetta aveva acquisito un
bagaglio di cognizioni tecniche superiore a quello posseduto da uomini esperti
e capaci vissuti due o tre secoli prima di lei.
Era intelligente, e in più era anche istruita. Se non avesse accumulato un patrimonio di esperienza adeguato ai livelli raggiunti dal progresso tecnico alla metà del XX secolo, avrebbe certo fatto una brutta fine. I cani campagnoli capitati casualmente in città, infatti, sopravvivevano nelle strade urbane non più di qualche ora.
Ma per la lotta in cui era costantemente impegnata,
esperienza e cognizioni tecniche non erano sufficienti, era indispensabile
comprendere l’essenza della vita, occorreva una saggezza di vita.
La bastardina senza nome e dall’ampia fronte sapeva
che il continuo cambiamento e il vagabondaggio erano il fondamento stesso della
sua sopravvivenza.
Poteva accadere che qualche persona di buon cuore si mostrasse compassionevole nei confronti di quella pellegrina a quattro zampe, le desse da mangiare, le permettesse di passare la notte sulle scale di servizio. Rinunciare a una vita randagia significava morte sicura. Diventando sedentaria, avrebbe avuto a che fare con una persona d’animo buono e con cento malvagie. E ben presto sarebbe apparsa, subdola, la morte, porgendo con una mano un pezzo di pane, e tenendo nell’altra una rete di tela ruvida. Cento cuori malvagi sono più forti di un cuore buono.
La gente pensava che una cagnetta vagabonda non
fosse capace di affezionarsi, che il vagabondaggio l’avesse guastata senza
rimedio.
La gente si sbagliava. La vita dura non aveva
incattivito la cagnetta randagia, ma nessuno aveva bisogno del bene che viveva
nel suo cuore.
La presero di notte, nel sonno. Non la uccisero, la portarono all’Istituto. Le fecero fare un bagno in un liquido caldo e maleodorante, e le pulci smisero di tormentarla. Per qualche giorno la tennero in uno scantinato, dentro una gabbia. La nutrivano bene, ma lei non aveva voglia di mangiare. Un presentimento di morte non le dava tregua, soffriva per la privazione della libertà. Soltanto in quella gabbia, con una cuccia soffice e una ciotola linda piena di buon cibo, la cagnetta apprezzò la fortuna di una vita libera.
La irritava il latrare ottuso dei vicini. Gente in
camice bianco la esaminò a lungo, uno di loro, un uomo dagli occhi chiari,
magro, le diede un buffetto sul naso e le accarezzò la testa; ben presto la
trasferirono in un luogo tranquillo.
Stava per entrare in contatto con la massima
espressione della tecnica del Ventesimo secolo, cominciarono a prepararla per
una grande impresa.
Le diedero un nome, Pestruška.
Con ogni probabilità neppure imperatori e primi ministri malati erano mai stati sottoposti a tante analisi. Aleksej Georgievič, l’uomo magro dagli occhi chiari, venne a sapere tutto ciò che era possibile sapere su cuore, polmoni, fegato, metabolismo, composizione del sangue di Pestruška, sulle sue reazioni nervose, sui suoi succhi gastrici.
La cagnetta capiva che non erano le donne delle
pulizie né i tecnici di laboratorio né i generali con il petto coperto di
decorazioni a disporre della sua vita, della sua morte, della sua libertà,
delle sue ultime pene.
Lo capiva, e l’amore intatto di cui era capace il
suo cuore lo donò ad Aleksej Georgievič: neppure tutto l’orrore del presente e
del passato poteva inasprirla nei suoi confronti.
La cagnetta capiva che le iniezioni, i prelievi, i viaggi stordenti e nauseanti dentro le centrifughe e i test di vibrazione, l’angosciosa sensazione di assenza di peso che le pervadeva la coscienza, le zampe anteriori, la coda, il petto, le zampe posteriori – capiva che tutto questo era opera di Aleksej Georgievič, il padrone.
Ma la sua ragion pratica si rivelava impotente. La
cagnetta aspettava il padrone che si era trovata, si struggeva quando lui non
c’era, si rallegrava nel sentire i suoi passi, e la sera, quando lui se ne
andava, gli occhi castani dell’animale parevano inumidirsi di lacrime.
Di solito dopo l’addestramento del mattino,
particolarmente pesante, Aleksej Georgievič passava dallo stabulario –
Pestruška, la lingua di fuori, il respiro affannoso, la testa dall’ampia fronte
reclinata sulle zampe, lo contemplava con sguardo mansueto.
In qualche strano, inspiegabile modo, la cagnetta associava l’immagine dell’uomo diventato padrone della sua vita e del suo destino alla sensazione di quella tiepida, verde foschia primaverile, a un senso di libertà.
Guardando l’uomo che le infliggeva prigionia e
tribolazioni, Pestruška sentiva nascere nel proprio cuore la speranza.
Aleksej Georgievič non si accorse subito di provare
per lei un sentimento di pietà, di compassione, e non il consueto interesse
scientifico, determinato dal lavoro.
Un giorno, osservando quel cane da laboratorio,
pensò a quanto fosse irragionevole e assurda la quotidiana dedizione di
migliaia e migliaia di allevatrici di pollame e allevatori di suini per gli
animali che essi stessi preparavano al supplizio e alla morte. E altrettanto
assurdi, insensati erano gli occhi mansueti della cagnetta, il suo naso umido
fiduciosamente appoggiato sulla mano del carnefice.
Passavano i giorni, si avvicinava l’inizio della missione per cui Pestruška veniva addestrata. Era sottoposta a varie prove dentro un’ampia cabina; il viaggio straordinariamente prolungato dell’animale a quattro zampe preludeva al lungo volo dell’essere umano nello spazio.
Aleksej Georgievič era unanimemente detestato dai
sottoposti. A qualche ricercatore faceva molta paura – era irascibile, non
aveva alcuna remora a prendere severe misure disciplinari nei confronti dei
tecnici di laboratorio. I superiori non lo amavano a causa della sua indole
litigiosa e vendicativa.
Anche a casa non era una persona facile; spesso gli
faceva male la testa, e allora il minimo rumore lo irritava. A causa della
gastrite, soffriva di bruciore di stomaco, ma dava la colpa al cibo non
adeguato, pensava che sua moglie non si preoccupasse abbastanza per lui e
aiutasse di nascosto i propri numerosi parenti.
Anche i rapporti d’amicizia non erano semplici; aveva frequenti scatti di nervi, sospettava che gli amici provassero per lui indifferenza o sorda invidia. Dopo aver litigato con uno di loro stava male e allora voleva riconciliarsi, cercava faticosamente un chiarimento.
Ma neppure di se stesso Aleksej Georgievič era
entusiasta, tutt’altro. Gli capitava di borbottare amaramente: «Ora ho proprio
stufato tutti, me per primo».
La bastardina dalle zampe storte non tramava contro
di lui sul posto di lavoro, non trascurava la sua salute, non si dimostrava
invidiosa.
Lei, come Cristo, rispondeva al male con il bene,
gli dava amore in cambio delle sofferenze che lui le causava.
Mentre Aleksej Georgievič esaminava gli elettrocardiogrammi, i dati sulla pressione del sangue e sui riflessi, la cagnetta lo osservava attenta con i suoi occhi castani pieni di devozione. Una volta lui cominciò a spiegarle ad alta voce che quello stesso ciclo di addestramento toccava anche agli uomini, e non era piacevole nemmeno per loro; certo, i rischi che la attendevano erano maggiori di quelli corsi dagli uomini, però il suo caso non era neppure paragonabile a quello della cagnetta Lajka che era andata incontro a morte certa.
Un’altra volta disse a Pestruška che lei sarebbe
stata il primo essere vivente, da quando esisteva il pianeta Terra, a vedere il
cosmo profondo. Che sorte meravigliosa le era toccata! Irrompere nello spazio
cosmico, diventare la prima ambasciatrice della libera ragione nell’universo.
Gli sembrava che la cagnetta capisse ciò che le
diceva.
E, a modo suo, era straordinariamente intelligente, di un’intelligenza canina, s’intende. Tecnici di laboratorio e inservienti scherzavano: 'La nostra Pestruška si è diplomata all’istituto tecnico'. Era del tutto a proprio agio in mezzo alle apparecchiature scientifiche, si sarebbe detto che conoscesse i princìpi di funzionamento degli strumenti, tanta era la naturalezza con cui si muoveva in quell’ambiente di terminali elettrici, morsetti, schermi, lampade elettroniche, mangiatoie automatiche.
Aleksej Georgievič era capace come nessuno di
ricavare un quadro complessivo delle funzioni vitali di un organismo che si
trovava in volo nello spazio vuoto a migliaia di chilometri di distanza dai
laboratori terrestri.
Era uno dei fondatori di una nuova scienza: la
esobiologia. Ma in quel caso ciò che lo appassionava non era la complessità del
problema. Con la cagnetta dalle zampe storte nulla andava come al solito.
Gli occhi di Pestruška avrebbero visto tutto
questo, e Aleksej Georgievič sentiva che al ritorno gli avrebbero trasmesso ciò
che avevano visto. Leggendo quegli occhi, egli avrebbe capito il più criptico
dei cardiogrammi, l’arcano cardiogramma dell’universo.
Pareva che la cagnetta avvertisse con l’istinto il
fatto che l’uomo l’aveva iniziata alla più grande impresa della storia, le
aveva offerto un magifico primato.
I superiori e i sottoposti di Aleksej Georgievič,
così come i familiari e gli amici, avevano notato in lui strani cambiamenti –
non era mai stato così conciliante, amabile, malinconico.
Il nuovo esperimento era senza precedenti. Non solo perché, a differenza di quanto era sempre accaduto, quella volta la navicella avrebbe lasciato un’orbita circolare per addentrarsi nello spazio cosmico, allontanandosi di centomila chilometri dalla Terra.
A contare più di tutto, nel nuovo esperimento, era
il fatto che un animale, con la propria psiche, avrebbe potuto irrompere nel
cosmo. No! Al contrario! Il cosmo avrebbe potuto irrompere nella psiche di un
essere vivente. Ormai non era più questione di sovraccarico limite, di
vibrazioni, di imponderabilità.
Davanti a quegli occhi la superficie piatta della
Terra avrebbe cominciato a incurvarsi, gli occhi di un animale avrebbero
confermato l’intuizione di Copernico. Il globo! Il geoide! E ancora avanti,
ancora più lontano... Un sole ringiovanito di due miliardi di anni si sarebbe
levato dalla nera vastità dello spazio di fronte agli occhi della cagnetta
dalle zampe storte. Una fiamma arancio vivo, lilla, violetta avrebbe
inghiottito l’orizzonte terrestre. Il meraviglioso globo, chiazzato di nevi e
sabbie ardenti, colmo di una vita stupenda e irrequieta, non solo avrebbe
veleggiato lontano, sfilandosi da sotto le zampe dell’animale, ma sarebbe
scivolato via dalla sua percezione vitale. Allora le stelle, acquisita una
concretezza corporea, sarebbero diventate carne termonucleare, materia
incandescente, sfolgorante.
Nella psiche di un essere vivente sarebbe penetrato un regno non avvolto dal calore terrestre, dalle morbide nubi cumuliformi, dall’umida forza del flogisto. Per la prima volta gli occhi di un essere vivente avrebbero visto l’abisso privo d’aria, lo spazio di Kant, lo spazio di Einstein, dei filosofi, degli astronomi, dei matematici senza sintetizzarlo in un pensiero astratto o in una formula, ma così com’è, senza monti né alberi, senza grattacieli né isbe contadine.
Le persone che circondavano Aleksej Georgievič non
capivano che cosa gli stesse succedendo.
Lui sentiva che avrebbe raggiunto un nuovo livello
di conoscenza, superiore a quello derivante dalle equazioni differenziali e
dalle indicazioni degli strumenti. Il nuovo livello di conoscenza sarebbe stato
trasmesso da anima ad anima, dagli occhi di un essere vivente a quelli di un
altro essere vivente. E tutto ciò che turbava e irritava Aleksej Georgievič,
che suscitava in lui sospetto e risentimento, perse ogni significato.
Aleksej Georgievič aveva l’impressione che una qualità nuova si stesse apprestando a entrare nell’esistenza delle creature terrestri, ad arricchirla ed elevarla, e che quel dato nuovo gli sarebbe valso come perdono e giustificazione.
Il volo spaziale fu effettuato.
L’animale fu proiettato nelle profondità dello
spazio. Oblò e schermi erano stati disposti in modo che, ovunque volgesse la
testa, potesse vedere solo lo spazio cosmico, perdendo ogni usuale percezione
terrestre. L’universo irruppe nella mente della cagnetta.
Aleksej Georgievič era convinto che il contatto con
Pestruška non si fosse interrotto, lo sentiva anche quando la navicella
spaziale era lontana centomila chilometri dalla Terra. Questo contatto
prescindeva dalla telemetria e dai segnali radio automatici che registrarono
una violenta accelerazione del battito cardiaco di Pestruška e frequenti sbalzi
della sua pressione arteriosa.
Al mattino il tecnico di laboratorio Apres’jan
riferì ad Aleksej Georgievič:
«Ha ululato, ha ululato a lungo». E aggiunse a
bassa voce: 'È una cosa agghiacciante, il lamento di un cane solo in mezzo
all’universo'.
Il funzionamento delle apparecchiature fu perfetto, di una precisione stupefacente. Il granello di sabbia lanciato nello spazio cosmico ritrovò la strada per tornare sulla Terra, per tornare sul granello di sabbia che l’aveva generato. Il sistema frenante funzionò in maniera impeccabile, la capsula atterrò nel punto prestabilito della superficie terrestre.
Il tecnico di laboratorio Apres’jan disse
sorridendo ad Aleksej Georgievič:
«L’impatto delle particelle cosmiche avrà
modificato i geni di Pestruška, i suoi cuccioli nasceranno straordinariamente
dotati per l’algebra superiore e la musica sinfonica. I nipoti della nostra
Pestruška comporranno sonate che non avranno nulla da invidiare a quelle di
Beethoven, costruiranno macchine cibernetiche, i nuovi Faust».
Aleksej Georgievič non replicò alle parole dello
spiritoso Apres’jan.
Aleksej Georgievič si recò personalmente sul luogo
di atterraggio della capsula spaziale. Doveva essere il primo a vedere
Pestruška. I suoi vice e assistenti in quel caso non potevano sostituirlo.
L’incontro fu così come voleva Aleksej Georgievič.
Pestruška gli corse incontro, muovendo timidamente
la punta della coda abbassata.
Per parecchio tempo Aleksej Georgievič non riuscì a
vedere gli occhi che avevano accolto in sé l’universo. La cagnetta gli leccava
docile le mani manifestando in quel modo la sua definitiva rinuncia alla vita
di viandante senza padrone, la sua riconciliazione con tutto ciò che era e
sarebbe avvenuto.
Finalmente lui riuscì a vedere i suoi occhi: gli
occhi annebbiati, impenetrabili di un povero essere dalla mente confusa e dal
cuore tenero e mansueto.
(V. Grossman)




.gif)
.gif)
.gif)
.gif)

















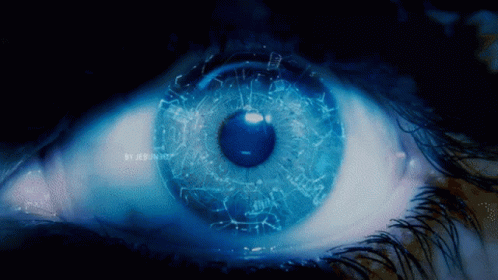
Nessun commento:
Posta un commento